Un destino segnato
Il 27 giugno 2025 si è concluso il mio percorso di studi al Politecnico di Milano.
Sembra un traguardo importante, ma per me è stato quasi un passaggio obbligato, essendo nato e cresciuto a pochi metri da Piazza Leonardo da Vinci (sede storica del Politecnico) - tra una madre filosofa e un padre ingegnere.
Nonostante tutto, ironicamente, la mia iniziale scelta di studiare Ingegneria dell’Automazione non si è rivelata azzeccata e, nel corso della laurea triennale, mi sono reso conto di voler assolutamente cambiare percorso di studi. È per questo che oggi voglio condividere alcune riflessioni sulla mia esperienza a Ingegneria.

Il mio ultimo pranzo al Polimi - Un'ora dopo il mio ultimo esame: in Autogrill con sconosciuti direzione Cortina D'Ampezzo.
Tanti giochi da tavolo
Ingegneria è difficile, inutile negarlo.
Ma lo è ancora di più se non ti appassiona ciò che stai studiando.Ho sempre pensato che ogni materia fosse come un gioco da tavolo, con regole proprie, e che l’obiettivo di ogni studente fosse quello di interiorizzare queste regole, capirne le dinamiche e le strategie, e infine “vincere” la partita: l’esame.
Chi ha mai passato una serata davanti a un gioco che non gli piace sa quanto possa essere noioso e pesante partecipare. La stessa cosa vale per Ingegneria.
Essere appassionati delle materie di studio non riduce le ore di studio necessarie per passare un esame, ma cambia radicalmente la fatica percepita e aumenta la curiosità nel comprendere i dettagli dell’enigma.
A differenza dei giochi da tavolo, però, le regole delle materie ingegneristiche non sono arbitrarie: quasi tutte possono essere dimostrate e dedotte dalle conoscenze precedenti. E quando si arriva alla fase finale di preparazione di un esame, quelle regole appaiono ovvie e quasi banali agli occhi di chi, per passione o per necessità, le ha fatte proprie.

Giovani matricole che giocano a Risiko in una serata in sessione
A proposito di interesse e passione, penso che possano entrambe essere approssimativamente modellizzate come una funzione del grado di conoscenza verso la materia stessa.
Dalla mia esperienza, ho notato infatti che iniziare a studiare una materia è il primo passo per farsela piacere.
All’inizio del corso, quando il professore introduce la materia e non se ne sa ancora nulla, si verifica un massimo locale, dovuto all’entusiasmo e alla curiosità di iniziare qualcosa di nuovo. Con il progredire delle lezioni – e, almeno all’inizio, con una comprensione spesso limitata – l’interesse tende a decrescere. Solo nel momento in cui si inizia a studiare davvero la materia e si comprendono le “regole” della materia, il trend si inverte e la funzione diventa monotona crescente.
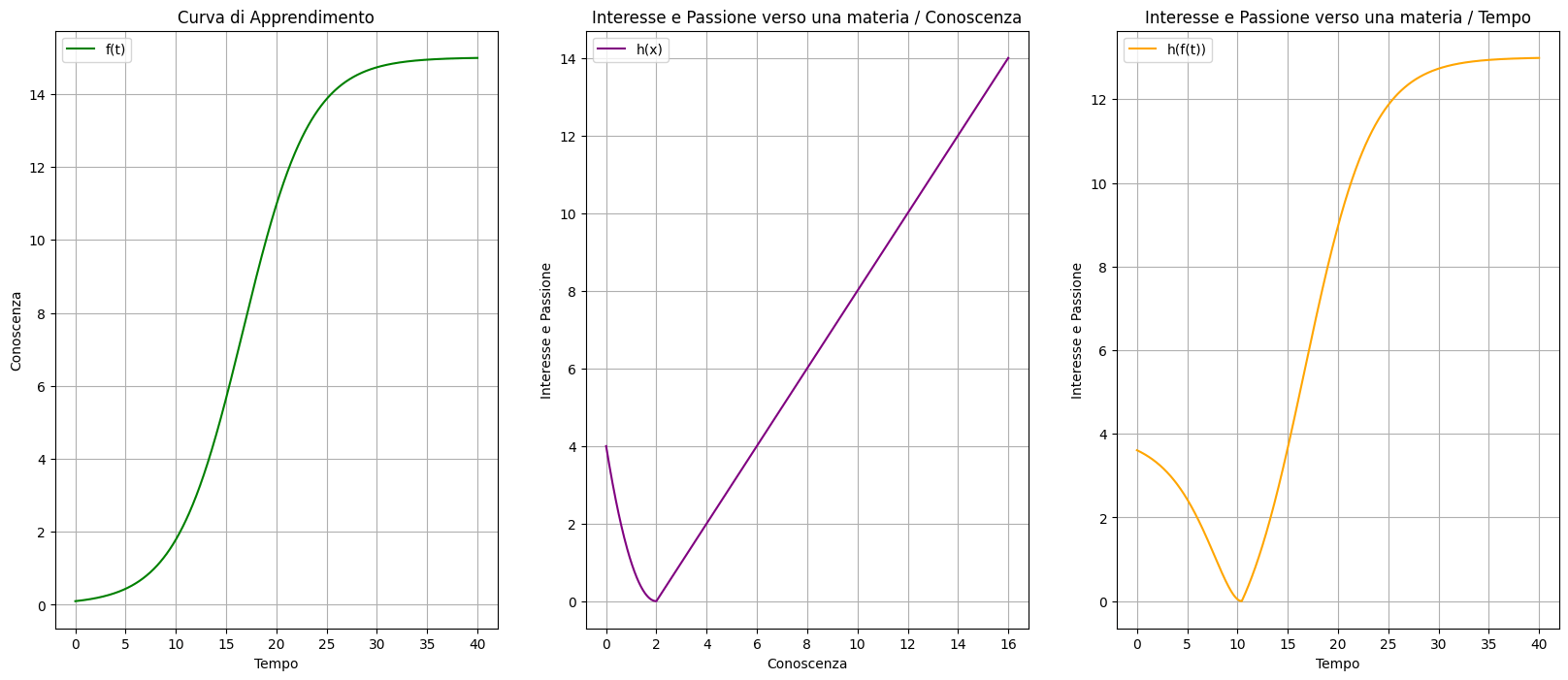
Un'approssimata modellizzazione di quanto accennato prima
Ti ricordi le Leggi di Ohm?
Come accennato in precedenza, “vincere una partita” — superare un esame — richiede elevate capacità di problem solving. Ed è proprio in questa caratteristica che risiede il grande valore formativo di ingegneria.
La maggior parte delle procedure, delle risoluzioni e delle nozioni apprese durante il percorso accademico risulteranno poco utili nel mondo del lavoro e verranno facilmente dimenticate. Tuttavia, l’approccio metodico e analitico necessario per analizzare, scomporre e risolvere un problema è qualcosa che difficilmente si dimentica e che potrà essere applicato in numerosi altri ambiti della vita.
Ritengo utile chiarire questo concetto attraverso due esempi tratti dalla mia esperienza universitaria.
Non vedo una particolare utilità pratica nel conoscere nel dettaglio le curve caratteristiche di un motore elettrico a corrente continua. Eppure, il processo mentale richiesto per comprenderle e disegnarle implica l’interconnessione di conoscenze pregresse provenienti da diverse materie (i principi base di elettrotecnica, il modello elettrico del motore DC, il modello meccanico). Richiede inoltre un ragionamento deduttivo per ricavare casi specifici da concetti generali, la capacità di modellizzare e interpretare matematicamente un fenomeno fisico e molte altre competenze logico-matematiche trasversali, non riconducibili a una singola disciplina, ma applicabili, una volta apprese, a molti altri settori.
Il secondo esempio proviene da un ambito che non ho mai studiato in modo sistematico ma che mi ha sempre affascinato: l’informatica (ironicamente, è stata anche la materia in cui ho preso il voto più basso della mia carriera universitaria).
Durante la triennale in Ingegneria Informatica, raramente si diventa esperti di uno specifico linguaggio di programmazione. Più saggiamente, vengono insegnati concetti, algoritmi e metodologie generali, applicabili in qualsiasi ambiente di sviluppo. L’obiettivo è costruire una “forma mentis” solida, con la consapevolezza che tali concetti potranno essere facilmente adattati ai diversi contesti professionali, imparando all’occorrenza la sintassi dei singoli linguaggi.
A questo proposito, mi permetto di affermare che le basi dell’informatica - algoritmi fondamentali, elaborazione dell’informazione, architettura di un computer - insieme alla programmazione di base - variabili e strutture dati, operatori logici e aritmetici, strutture di controllo, funzioni e modularizzazione, concetto di bug, debugging e testing - dovrebbero essere incluse nei programmi di tutte le scuole superiori e in tutti i corsi universitari. Non tanto perché il mondo abbia bisogno di più informatici, ma perché queste materie sviluppano il pensiero critico e allenano l’elasticità mentale tanto quanto — se non più di — discipline tradizionali come la matematica o la traduzione dal latino.
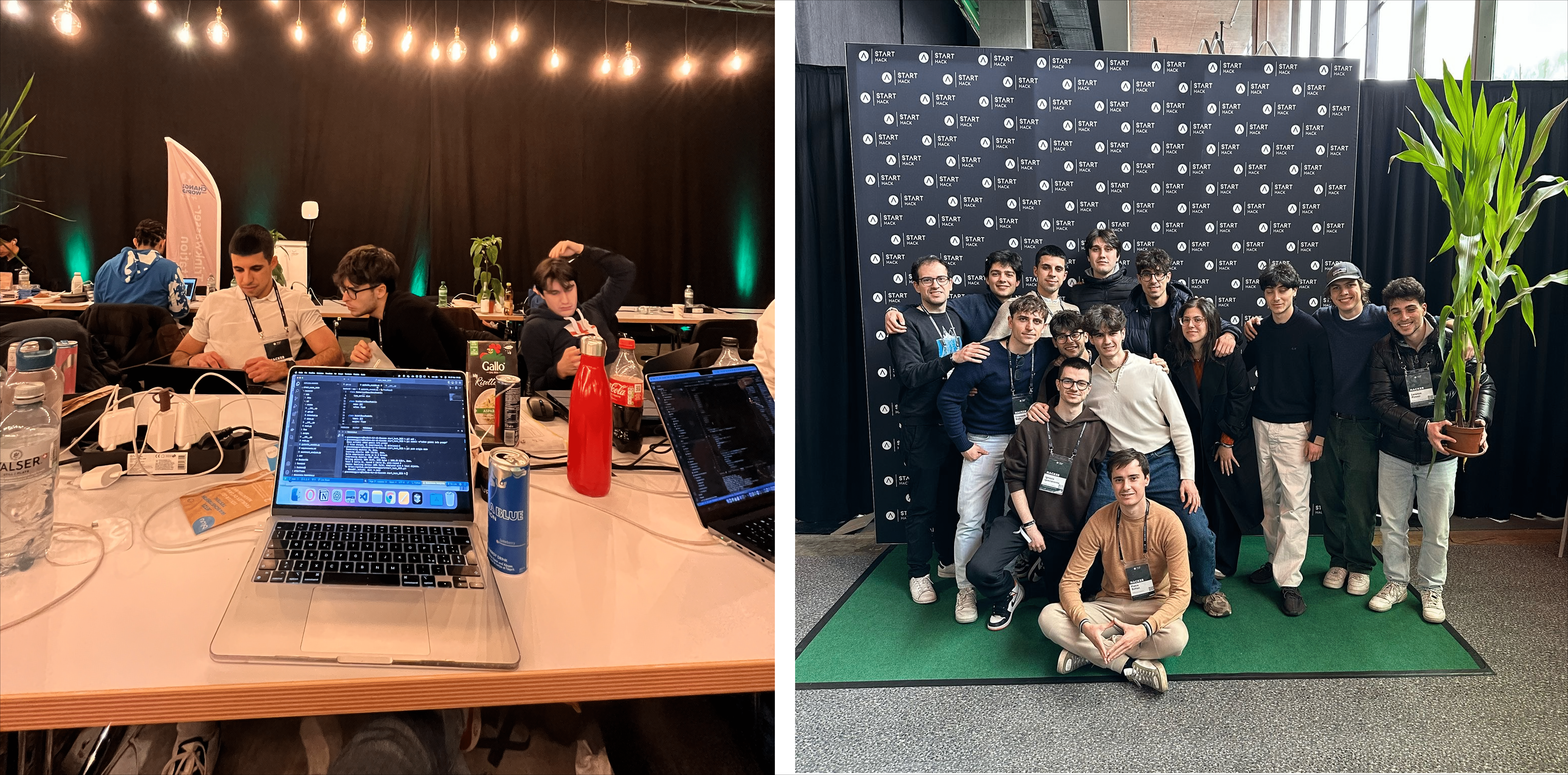
Ricordi da Start Hack 2025, il primo hackaton a cui ho partecipato, nonchè uno degli eventi più memorabili, formativi e divertenti dei miei anni a Ingegneria.
Ma le dimostrazioni sono inutili
In questi anni di ingegneria, non sono mancate da parte mia le critiche al sistema universitario. Nonostante queste osservazioni nascano da una posizione privilegiata all’interno del Politecnico di Milano, ritengo che possano essere estese anche a molti altri atenei italiani.
Pur attribuendo grande valore agli aspetti più teorici (e talvolta poco utili nella pratica) dei corsi, e sostenendo che sia più importante costruire una forma mentis piuttosto che una singola skill, durante questi tre anni mi sono spesso sentito completamente incapace di fare qualsiasi cosa in modo concreto.
A mio avviso, sarebbe sufficiente un piccolo sforzo in più — maggiori CFU dedicati a laboratori, esami con una componente pratica più rilevante, utilizzo di software specifici durante lezioni, esercitazioni e in fase di valutazione, più di lavori di gruppo — per sviluppare anche competenze pratiche, dare un significato tangibile a ciò che si sta studiando e, cosa ancora più importante, far appassionare maggiormente gli studenti.
Sono ben consapevole che questo tipo di cambiamento richiederebbe un impegno maggiore e un investimento di risorse da parte dell’ateneo, dei docenti e perfino degli studenti stessi (che spesso preferiscono l’esame classico, basato esclusivamente sulle lezioni frontali, senza laboratori o attività aggiuntive). Tuttavia, credo fermamente che una didattica più orientata all’esperienza porterebbe un miglioramento tangibile nella qualità dell’insegnamento e arricchirebbe l’esperienza universitaria sotto molteplici aspetti.
(Queste riflessioni sull’ampliamento dell’offerta formativa mi sembrano oggi più attuali che mai. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale sembra poter fare tutto e le conoscenze sono sempre meno considerate un valore in sé, mi prometto di approfondire questo tema in un secondo momento.)
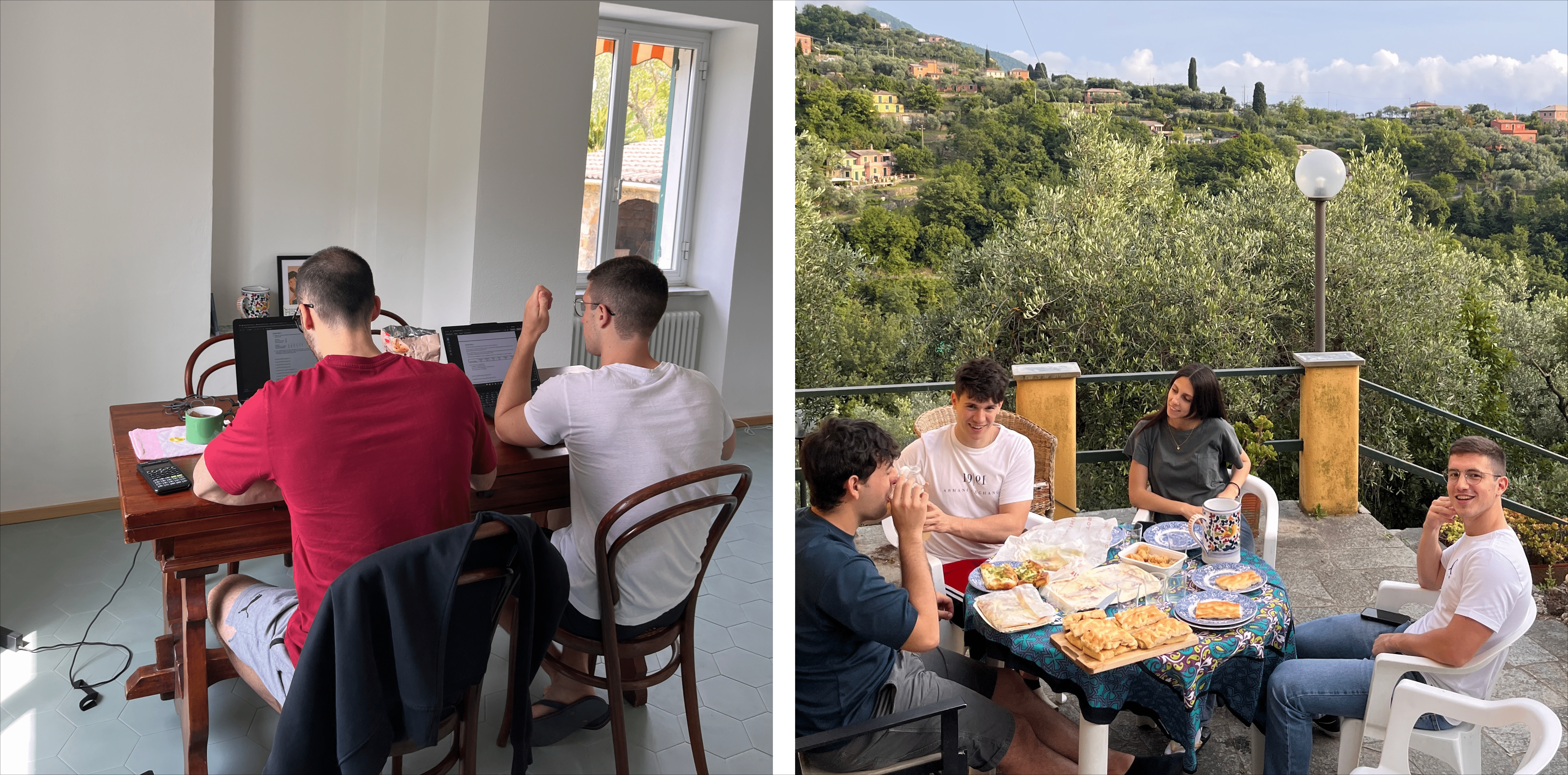
Come ho preparato la mia ultima sessione: qualche giorno a Recco (GE) per confrontarsi assieme sugli argomenti d'esame
Overfitting degli esami
Un’altra criticità che ho riscontrato — strettamente collegata ai punti precedenti e all’analogia tra “gioco” ed “esame” — è che ottenere un buon voto, nella maggior parte dei casi, non corrisponde realmente all’aver compreso a fondo i concetti trattati durante il corso. Come già accennato, il voto riflette spesso la capacità dello studente di imparare e padroneggiare le “regole del gioco”, più che la sua comprensione effettiva della materia. Molto frequentemente, infatti, è possibile ottenere ottimi risultati studiando a partire dagli esami degli anni precedenti, applicando un vero e proprio “overfitting” su dati storici, più che sviluppando una reale padronanza dei contenuti.
Non intendo affermare che questo sistema di valutazione sia del tutto inefficace o privo di logica — anche perché sono certo che il Politecnico, se ne avesse le risorse, adotterebbe soluzioni migliori — ma credo che potrebbe essere migliorato con relativa facilità, integrando modalità di valutazione più orientate allo sviluppo di competenze concrete, come progetti pratici, attività laboratoriali e lavori di gruppo.
Bocconi? No, grazie.
Come accennato in precedenza, ritengo estremamente valido il percorso di studi in ingegneria non tanto per le competenze tecniche acquisite, quanto per il modo di pensare e affrontare i problemi che si sviluppa nel corso degli anni. È anche per questo motivo che, forse in maniera un po’ presuntuosa e sicuramente influenzata dalla mia esperienza personale, sono convinto che dopo una laurea in ingegneria si possa affrontare - quasi - qualsiasi altra disciplina.
Se ripenso agli ultimi tre anni, tutte le volte in cui ho voluto approfondire un argomento - non necessariamente STEM e non per forza legato all’Ingegneria dell’Automazione - ho sempre sentito di avere gli strumenti logici e le basi matematico-scientifiche per farlo.
Questo non significa, ovviamente, che tutto sia stato facile o che sia sempre riuscito a raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissato. Significa però che non mi sono mai sentito completamente “perso” o spaesato di fronte a un nuovo compito.
Tornando alla mia esperienza personale, ricordo che tre anni fa ero indeciso se iscrivermi a Economics, Management and Computer Science alla Bocconi oppure intraprendere un percorso più tradizionale e tecnico al Politecnico di Milano. Molti, all’epoca, mi dissero: “All’inizio è meglio costruirsi un background tecnico e ingegneristico. In futuro avrai sempre modo di cambiare.”
Oggi, in quel futuro che è ormai diventato presente, non posso che essere d’accordo con quel consiglio e grato per averlo ricevuto.Non so dove sarei adesso se tre anni fa avessi varcato le aule della Bocconi, ma, nonostante sia certo di non voler progettare sistemi di retroazione o robot nel mio futuro professionale , resto comunque molto soddisfatto — sia dal punto di vista didattico che personale — del mio percorso al Politecnico di Milano.